L’organizzazione antropica*
L’organizzazione “antropica”
Se chiediamo a qualcuno di descrivere che cosa intenda per organizzazione, nella risposta sceglierà tra un aspetto “esteriore” (chiamiamo organizzazione anche un ente) e uno “interno” riferito al sistema di assegnazione dei compiti, cioè “chi fa che cosa”.
Se poi insistiamo e chiediamo che cosa compone una “organizzazione”, la risposta si fermerà alle componenti classiche che individuano le componenti nel sistema delle regole, nei meccanismi di funzionamento e nelle finalità da condividere.
Difficilmente la descrizione di una organizzazione si spinge fino a prendere in considerazione “le persone” che la compongono. E nella migliore delle ipotesi quelle persone vengono definite “risorse umane” o “capitale umano”. Che è un modo per renderle simili agli oggetti in modo da poterle “allocare” all’interno dell’organizzazione, al pari degli oggetti.
Ricordo che nella mia prima esperienza di direttore generale qualcuno mi contestò duramente perché avevo disegnato l’organizzazione dell’ente basandomi sulle persone di cui disponevo. Destai scandalo perché secondo il metodo che si apprende sui libri di management avrei dovuto agire in senso opposto cioè, prima disegnare il modello organizzativo ideale e perfetto e poi portare le persone ad adattarsi.
Il vero problema, per chi studia organizzazione aziendale è che gli autori dei libri, di solito, non hanno alcuna esperienza di ciò che scrivono. Producono teorie ipotetiche sulla base di ragionamenti solitari, citando altri studiosi (anch’essi senza esperienza concreta) e non lavorando trovano il tempo di produrre scritti numerosi e corposi che vengono considerati come testi di riferimento, perché nessuno si pone la domanda cruciale: queste teorie così bene rappresentate e argomentate, sono state mai sperimentate realmente?
Chi vive ogni giorno e concretamente la direzione aziendale, purtroppo non ha il tempo di scrivere per raccontare la propria esperienza, in modo da poterne cogliere gli aspetti relativi alla reale organizzazione delle attività. E così il mondo “scientifico” (il termine è impropriamente utilizzato) pullula di “esperti” (altro termine impropriamente utilizzato) che illustrano metodi e teorie di cui non hanno alcuna conoscenza pratica, cioè nessuna esperienza.
Varrebbe la pena, per l’occasione, di citare la famosa frase: tra teoria e pratica non c’è differenza, in teoria, ma in pratica si.
Se si ha la fortuna di incontrare qualcuno che ha diretto effettivamente un’azienda o un ufficio si rileva subito che la prima qualità di chi dirige consiste nella capacità di cogliere tutti quegli aspetti che sfuggono al “management degli esperti”.
Già nei primi anni del novecento, Adriano Olivetti, che studiava l’organizzazione partendo dalla propria e facendolo con successo, affermava: “La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica.”
Sono trascorsi diversi anni da allora, ma ancora si parla di quella intuizione che spinge nella direzione di ciò che diventerà, negli anni successivi, oggetto della sociologia del lavoro. E che possiamo semplificare affermando: “sono le persone che determinano il successo delle organizzazioni”.
Le migliori organizzazioni non sono quelle che hanno buone regole o buone procedure, ma quelle che dispongono di persone che a quelle regole e a quelle procedure sanno attribuire il giusto “valore”. E perché ciò accada è necessario che le regole e le procedure siano funzionali e adattate al contesto umano che deve trasformarle in “valore aggiunto”.
Il successo di un’organizzazione dipende dall’approccio direzionale che si sceglie di adottare. Si può scegliere l’atteggiamento teorico e distaccato per il quale, dopo avere progettato l’organizzazione ideale, si deve lavorare intensamente per condurre le persone verso quel modello. E non è un lavoro da poco perché richiede il cambiamento di abitudini, prospettive, paradigmi organizzativi. Tutti elementi che risiedono nella testa e nell’immaginazione di chi progetta che trasferisce l’onere del funzionamento alla capacità di ciascuno di saperli comprendere e mettere in atto. E che conserva sempre un alibi: se l’organizzazione non funziona è colpa di chi non l’ha messa in atto. Cioè degli altri.
Ricordo un ingegnere gestionale che mi disse “il modello organizzativo che ho prodotto è perfetto, è la gente che è sbagliata”. Gli feci notare che il nostro compito, nella circostanza, era quello di fare funzionare quella organizzazione, nelle condizioni in cui si trovava.
Si può scegliere, invece, un approccio diverso che punta a progettare l’organizzazione in funzione delle persone di cui dispone, costruendola intorno a loro, in ragione delle caratteristiche di ciascuno. In questo modo l’onere dell’organizzazione è interamente riversato su chi progetta e chi dirige. Come è giusto che sia.
E poiché le persone, se ben coordinate e “attenzionate” riescono a crescere in esperienza, conoscenze e abilità, con il passare del tempo l’organizzazione può evolversi e migliorare in funzione delle nuove professionalità e delle nuove consapevolezze.
Ma perché il modello “antropico” possa funzionare è necessario avviare un processo continuo di coinvolgimento e di integrazione che consenta a ciascuno di avvertire l’appartenenza all’organizzazione fino a sentirsi responsabile del ruolo rivestito e dei risultati che vengono raggiunti collettivamente
*) articolo scritto per www.lentepubblica.it

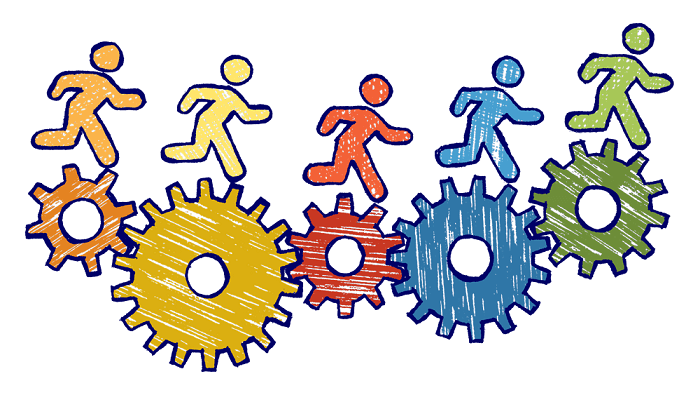









 Users Today : 208
Users Today : 208 Users Yesterday : 369
Users Yesterday : 369 Total Users : 427236
Total Users : 427236 Views Today : 407
Views Today : 407